P.I. 12087340969
Social
Contatti
Indirizzo
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Lombardia
n. 19417
Via Dante Alighieri 25
20060 Gorgonzola (MI)
Recensione aprile 2022

Liberati della brava bambina:
otto storie tra mito e leggenda per raccontare una sindrome tutta al femminile
Cosa significa essere donna? Una domanda che prepotentemente evoca stereotipi, culturali, sociologici, biologici, appartenenti ad ogni epoca. Ogni risposta nella storia dell’umanità ha veicolato un messaggio incline a velare una figura di donna forte, a considerarla un’eccezione, quasi un’anomalia spesso da non considerare o da leggere come difettosa rispetto ad un’immagine più rispondente ai cosiddetti criteri femminili “naturali” identificati in una innata propensione alla sottomissione intesa come necessità di guida e protezione, una dipendenza dalle emozioni e dunque una irrazionalità pericolosa, una inferiorità fisica che giustifica la sopraffazione. Femminilità, dunque, come equivalente di debolezza sia fisica che mentale, motivo per cui essere donna ha sempre corrisposto ad una figura inferiore a quella maschile. Il comportamento adeguato conseguente a questa ideologia di donna è di non alzare la voce, non ribellarsi, obbedire al padre, al marito, alla società con atteggiamenti di calma e sottomissione. Essere donna significa dover essere una brava bambina, poi una brava moglie e una brava madre.
CONTENUTI
Gli autori del libro “Liberati della brava bambina”, Maura Gancitano e Andrea Colamedici attraverso una chiave di lettura filosofica che utilizza un linguaggio semplice e uno stile scorrevole, rivisitano la concezione e il significato dell’essere donna attraverso la simbologia del mito e dell’immaginario collettivo espresso attraverso generazioni e culture appartenenti alla storia dell’umanità. Per questo excursus propongono l’analisi critica di otto figure femminili che incarnano nella loro storia il ruolo designato alle donne, ritenuto inconfutabile e ineluttabile. Era, Medea, Daenerys, Morgana, Malefica, Difred, Elena, Dina condividono nelle loro storie l’intento di trovare modi diversi di vivere se stesse e la propria femminilità, di leggere i meccanismi che circondano e intrappolano per trasformare le gabbie in chiavi e volgere le difficoltà in opportunità. Desiderano finalmente permettere a se stesse di esistere, e non aver paura di fiorire, cambiare in quesiti le affermazioni di giudizio vincolanti: non più dunque “donna”, ma “donna?”, non più “si fa così”, ma “si fa così?”, non più “è sempre stato così”, ma “è sempre stato così?”. In questo modo ogni certezza esplode, e si consente di esistere a prospettive impensabili e altrimenti invisibili.
Il problema senza nome
Il libro non si presenta solo come una rilettura di storie di personaggi femminili nuovi o del passato, ma da voce a quello che definisce il problema senza nome, nel suo costituirsi e nella sua possibile risoluzione. Spesso nella donna nasce una sensazione che la rende infelice, anche se ha fatto ciò che c’era da fare, anche se ha raggiunto ciò che si era prefissata. Questa sensazione viene descritta come “una tessera che non s’incastra bene dov’è collocata, un tassello mancante, un problema senza nome”: è un sentimento d’insoddisfazione e d’inquietudine tipicamente femminile che appare violentemente e concede brevi tregue nei periodi in cui i ritmi di vita aumentano, per ripresentarsi puntualmente poi. I tentativi di porre fine a questa sofferenza, insidiosa e apparentemente senza motivo d’essere, inducono la donna ad una meticolosa analisi di se stessa finalizzata alla ricerca di un difetto, di un errore commesso che dia giustificazione al sentimento provato. Ma non trova nulla per motivarlo, nulla che lo riconduca ad un fatto individuale. Questo perché il problema senza nome non è il retaggio di un vissuto colpevole né il frutto di uno stile di vita sbagliata e non è nemmeno il senso di colpa dovuto ad una scelta erronea che si è compiuta e poi rimossa. La ragion d’essere di questa insoddisfazione è semplicemente radicata nella necessità invisibile ma minacciosa di difendersi dalle accuse di essere eccessiva, nella paura costante di dover adeguarsi alla storia delle donne prima di lei costellate di abusi, violenze, silenzi, paura di essere sbagliata nei suoi bisogni, percepita come troppo aggressiva o troppo remissiva…il problema senza nome dunque si alimenta del condizionamento subdolo che passa da generazione a generazione, mascherato a seconda del contesto storico/culturale/religioso da ragioni biologiche, sociali o spirituali che coniuga negativamente la dimensione femminile anche con i termini che vengono ricondotti ad essa: uterino, instabile, emotività, millanteria, eccesso, irragionevolezza …
Ancora oggi in una società che si proclama progressista e paritaria, è forte il richiamo al pensiero che essere donna sia un destino ed essere femminile significhi riconoscersi in determinati cliché anche corporei. Ogni scelta divergente è percepita come disarmonica, non naturale. Tutta questa influenza scelte, decisioni, relazioni che anche quando vengono adottate provocano nel profondo la sensazione di convivere con un problema senza nome, irrisolvibile: fai pure quello che vuoi, ma stai attenta a non perdere la tua femminilità.
Le storie che trasgrediscono questo concetto di donna raccontano di personaggi femminili che diventano pazze, vengono uccise o rimangono sole. Gli autori di questo libro propongono un viaggio che, partendo da una riflessione personale, permetta una chiave di lettura dal punto di vista femminile attraverso le scelte delle protagoniste.
Era o il tradimento
La storia di Era rappresenta il primo aspetto del problema senza nome, la rinuncia alla realizzazione dei propri bisogni/progetti. La dea è raccontata come una grande dea madre in una società patriarcale che, a partire dai miti omerici, la descrive come una moglie repressa e petulante. In questa chiave di lettura della storia di Era viene enfatizzata la sua gelosia e la sua inarrestabile propensione alla vendetta, ma poco viene raccontato sulle dinamiche coniugali in cui la dea viene a trovarsi dopo la seduzione di Zeus. I continui tradimenti a cui cerca di ribellarsi la spingono a tentare di fermare suo marito incatenandolo, ma questo le procura una terribile punizione che sancirà per sempre quale può essere il suo ruolo: quello di moglie brontolona e rompiscatole ma che non ha potere di contrastare le decisioni del marito. Questa se ci pensiamo è un’immagine della donna molto spesso prevista e attesa nel matrimonio..si accettano i tradimenti e di contro vengono tollerati i brontolii..si accetta di non decidere per sé ma di avere un ruolo sullo sfondo e di dare credito ai rimproveri sociali: “sei una donna fortunata, hai un marito dei figli una casa, pensa a chi è sola”
Malefica o la rabbia incontrollata
La storia di Malefica è la storia di una fata bellissima e potente tradita per ambizione di potere dal suo primo amore, Stefano che, tagliandole le ali, la priva della sua forza. Nella narrazione classica della fiaba Malefica è crudele al punto di impedire alla giovane Aurora di vivere liberamente, vendicando così il torto subito e macchiandosi dello stesso crimine di Stefano attraverso un gesto patriarcale inflitto ad una donna della generazione successiva: la costringe infatti in un sonno eterno. Viene messa in atto una dinamica antica: la rabbia nei confronti degli uomini e il dolore per l’ingiustizia ricevuta non diventano motore per liberarsi ma creano altre gabbie. E’ in questo modo che le stesse donne da vittime possono trasformarsi in carceriere di altre donne, soprattutto se giovani e piene di possibilità replicando la condanna sofferta con la stessa dinamica che in realtà vorrebbero sovvertire. Accade infatti che in preda alla rabbia si finisca per rovesciare la propria maledizione: il taglio delle ali sulle altre donne. Il conflitto tra le donne nasce proprio da qui: si diventa streghe cattive le une per le altre sebbene l’origine del dolore e della rabbia di ciascuna non derivi da loro ma dai condizionamenti sociali. Questi sentimenti dolorosi sono incontrollati, e profondi e rischiano di diventare un dono malefico transgenerazionale che le madri tramandano inconsapevolmente alle figlie. Una eredità che spesso è silente e appare come un riflesso incondizionato non come una scelta: è ciò che accade tra suocera e nuora, tra madre e figlia, tra amiche, tra colleghe di lavoro. In queste relazioni competizione, crudeltà e vendetta possono entrare in campo senza nemmeno accorgersene. Si innesca un meccanismo in cui la vendetta porta poca gratificazione, ma al contrario la rabbia aumenta e rinnova il dolore poiché continuando a ferire altre si continua a ferire se stessa.
Elena o la responsabilità delle proprie scelte
Elena è la moglie bellissima di Menelao, re di Sparta, rapita dal principe Paride e portata a Troia, motivo del conflitto durato dieci anni tra le due città, concluso con la vittoria di Menelao e del ritorno di Elena a Sparta. Il mito racconta che Zeus la creò per scatenare una lunga e aspra guerra tra gli uomini per alleggerire la madre terra Gaia, affaticata dal peso eccessivo degli esseri umani che sopportava.
Nonostante sia al centro della storia e causa dei fatti di guerra, di Elena nell’Iliade si parla poco ed appare come una figura sottoposta alle azioni e alla volontà di altri, rapita e ripresa senza che sia mai rappresentata una sua forma di scelta o decisione. L’unica sua virtù sembra essere la bellezza, peraltro causa di enormi. Per Eschilo Elena è donna dai molti uomini rovina di navi, rovina di eroi, rovina di città. La società a cui appartiene Elena non le riconosce dunque di essere pienamente responsabile delle sue decisioni perché vuole limitarla, controllarla, indirizzarla ma allo stesso tempo la ritiene responsabile, colpevole delle pulsioni che gli altri provano verso di lei. E’ impossibile che sia Elena a scegliere di seguire Paride ma è comunque colpa sua, della sua bellezza irresistibile se il principe l’ha rapita. Dunque, non può essere responsabile di ciò che fa ma è colpevole di tutto ciò che le accade. Riflettendo su questo processo di attribuzione di responsabilità ancora oggi una gran parte dell’opinione pubblica condanna una donna che subisce violenza in base a come era vestita, per una corta troppo corta, per un atteggiamento disinibito che induce allo stupro, perché troppo bella, provocatoria, irresistibile, seducente, perché ...in fondo se l’è cercata. Paradossalmente la donna è ritenuta bisognosa di una guida, incapace di decidere per se stessa, in uno stato di infantilismo psichico perenne. Le donne rischiano dunque di non essere considerate abbastanza mature da essere responsabili di scegliere, ma sempre colpevoli di ciò che accade.
La figura di Elena viene riletta dagli autori del libro e mette in luce la responsabilità delle sue scelte. Elena mette le donne davanti al fatto che non esistono vite perfette: esistono vite autentiche e vite inautentiche ossia vite percorse seguendo il cuore e vite cercando di reprimere costantemente i propri desideri. Essere una donna come Elena fa paura, incarna agli occhi degli uomini quello che Freud definiva perturbante, in tedesco unamnish, termine che indica allo stesso tempo un senso di familiarità e di estraneità e quindi genera attrazione e repulsione. Ogni vita autentica è una vita imperfetta, una finestra da cui guardare l’universo per decidere cosa vogliamo essere e dove vogliamo andare.
Difred o la libertà d’azione
Difred è la protagonista di “Il racconto dell’ancella” scritto da Margaret Atwood nel 1985 e ispiratore della serie tv The Handmaid's Tale. La storia è ambientata negli Stati uniti, in un futuro in cui vige un regime totalitario teocratico ispirato ai testi biblici, la "Repubblica di Gilead", che si insedia al potere dopo un golpe. In questo scenario vengono esplorati i temi della libertà di espressione e di pensiero delle donne a cui vengono negati tutti i diritti e che mantengono l’unica funzione di riproduzione della specie. Le donne non fertili o troppo anziane sono definite nondonne e uccise, le altre ridotte in schiavitù dai dirigenti maschi e sono riconosciute con il nome del comandante a cui appartengono: Difred in realtà prima della sua schiavitù era June.
Il modo in cui Difred ripercorre la sua vita passata e affronta la sua schiavitù del presente vengono letti come condizioni da non dare mai per scontate, da non accettare mai senza porle almeno per un attimo in discussione. Nessuna libertà è per sempre, nessuna dittatura è per sempre, bisogna difendere la libertà perché ci si abitua a tutto ma quando abituarsi significa rinunciare alla libertà bisogna agire e riprendersela ad ogni costo. Per questo bisogna domandarsi: a cosa mi sono abituata senza accorgermene?
Medea o il tradimento di sé
Medea è conosciuta come la madre rea dell’atrocità di aver ucciso i suoi figli per vendicarsi dell’abbandono. Medea è una maga molto potente che abdica i suoi poteri trasferendosi in terra straniera per divenire moglie di Giasone, conduttore della missione degli Argonauti nella ricerca del sacro Graal. Rinunciare a una parte essenziale di sé è una violenza autoinflitta per amore per la quale dovrà pagare un caro prezzo. Nella sua storia emerge l’importanza di comprendere che nella nostra vita ci sono delle cose a cui poter rinunciare, ce ne sono altre, delle necessità a cui si deve sempre dare ascolto. Fondamentale sempre mantenere l’attenzione su quelle parti importanti del nostro io dando loro sempre lo spazio vitale di cui hanno bisogno, senza cercare di soffocarle o silenziandole.
Daenerys o la conquista del potere
Daenerys Targaryen è la protagonista della saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. La sua storia è quella di una donna che cambia gli eventi drammatici della sua vita e riesce a farne un’opportunità. Esprime la ricerca di un potere ambito e inizialmente subito col dominio del volere maschile del fratello. Daenerys abbraccia quello che sembra essere il suo destino ma non gli permette di sopraffarla, lo muta nel suo divenire per sopravvivere prima, per emergere poi. Questo processo però la conduce a commettere molti errori e a scoprire il limite della sua ascesa dettato dal suo essere donna. Situazione spesso vissuta anche nella nostra società. La conquista del potere è possibile ma è molto facile per una donna che spesso si spinga solo fino a toccare il soffitto di cristallo, il limite imposto da un sistema precostituito che contiene e limita nell’espressione femminile. Con la sua storia Daenerys dimostra che il soffitto di cristallo può essere infranto, ma che per imparare a gestire davvero il potere bisogna sviluppare l’arguzia e l’umiltà e superare l’orgoglio.
Morgana o il conflitto con il mondo
La storia di re Artù, dei cavalieri della tavola rotonda e del grande mago Merlino affonda le sue radici nelle leggende britanniche e nei primi romanzi cortesi del medioevo in cui, ancora una volta, le figure femminili assumono un ruolo di spalla oppure sono antagoniste cattive, spietate, streghe crudeli e furiose molto diverse dall’equilibrato e saggio Merlino e dai temerari e forti guerrieri. Le nebbie di Avalon, romanzo scritto nel 1979 da Marion Zimmer Bradley, al contrario non racconta le gesta eroiche dei cavalieri ma la storia di Morgana e di Camelot, attraverso le parole della maga, che riesce così a dare voce alle donne che insieme a lei hanno visto il mondo che conoscevano cambiare radicalmente e l’isola di Avalon svanire per sempre nelle nebbie. Morgana, sorella di Artù, è la sacerdotessa di Avalon che tenta di preservare il culto della dea contro tutto e contro tutti: nessuna pazzia o irragionevolezza, ma il chiaro scopo di dedicare la propria vita ad un disegno più grande. Il culto della dea è basato sulla pace e sull’armonia con la natura, ma anche minacciato dal cristianesimo. Morgana tenta tutto ciò che è in suo potere per impedire che il suo mondo venga distrutto. Nonostante tutto si rende conto che la sua forzatura non è servita allo scopo e vive in un mondo in cui si sente ormai sola, condannata dal dono di prevedere il futuro che avanza, persa nell’illusione che la sua veggenza le dia il potere di cambiare le cose. Il conflitto con il mondo nasce infatti quando ci si accorge che c’è un cambiamento in atto e quando ci si rende conto che ciò a cui si tiene di più è in pericolo. Questo porta al bisogno di controllare e forzare il destino, ma ciò tuttavia peggiora solo la situazione perché le cose non vanno sempre nella direzione in cui vorremmo e si rischia di finire in un circolo vizioso, di sprecare energie. Non viene considerata la possibilità invece di comprendere e superare i conflitti che impediscono di stare al passo del cambiamento. Combattere perché certa di essere nel giusto, impedisce a Morgana di capire che il destino non può essere costretto e che le sue azioni inaspriscono le distanze e le differenze: non può interamente prevedere gli eventi futuri, spesso questi sono avvolti dalla nebbia e solo non tentando di forzarli ciò che è prezioso trova il modo di rimanere in vita.
Dina o il bisogno di condivisione
Dina è l’unica figlia di Giacobbe e sorella di latte di Giuseppe, celebrato in tante narrazioni come il principe d’Egitto. Di lei non si è parlato mai fino al romanzo scritto da Anita Diamant che ne racconta la storia. I temi trattati sono quelli legati al mondo delle donne, alla loro specificità biologica e a come questa influenzasse la vita in un mondo maschile. Nella tribù di Dina le donne durante il ciclo mestruale venivano condotte in una tenda rossa fino alla fine del loro sanguinamento, poiché considerate impure. Questo aveva permesso loro di creare un momento in cui condividere emozioni, pensieri, desideri senza dover mantenere gerarchie e distanze o ruoli, in assoluta sorellanza. Tale complicità viene scoperta però dagli uomini della tribù che entrano quindi nella tenda, infrangendone l’intimità e distruggendo i manufatti simboli della sorellanza. Dina vive un trauma che trova un momento di sollievo nell’amore condiviso qualche tempo dopo con un uomo molto ricco dal quale scopre di aspettare un figlio. I fratelli, venuti a conoscenza dell’amore consumato, uccidono l’innamorato e Dina, ormai sola e madre, accetta di allontanarsi dal figlio appena nato per vivere a casa del suo defunto amante come serva. Anche il suo nome viene denigrato, mutato in Denner. Ella accetta e sopporta chiudendosi nel silenzio: mantenere il segreto di ciò che ha perso le fa credere di poter continuare a vivere. Dina aveva ricevuto in passato dalle altre donne insegnamenti come levatrice, le piaceva aiutare le sue sorelle nel dolore, dando conforto. Di questo sente la mancanza, lo capisce ma non riesce a spezzare la gabbia di silenzi in cui si è rinchiusa. Fino al giorno in cui incontra una donna che le diventa amica e finalmente riesce a raccontare la sua storia, ricominciando a credere in un futuro nuovo che ora accetta e riconosce possibile. La storia di Dina sottolinea come la mancanza di un cerchio di donne che accolga e accompagni la vita di ciascuna possa produrre disorientamento, assenza di punti di riferimento e induca ancor più al silenzio. Sentirsi sorelle, uguali e adeguate nella propria specificità colma le distanze culturali, inibisce i tabù femminili come quelli legati alla ciclicità mestruale, permette una prospettiva di vita anche nelle difficoltà, regala fiducia e speranza. Anche quando la vita sembra finita e sembra sia impossibile una svolta nuova, il cambiamento può sempre avvenire. E’ necessario rimanere aperte alla propria vulnerabilità, senza nasconderla o negarla e alla possibilità di un finale diverso.
“Liberati della brava bambina” è un testo che invita a liberarsi delle idee degli altri, di quello che gli altri vogliono che tu sia. A lasciarsi andare, a non essere quella brava bambina che soddisfa ogni richiesta, ad essere solo se stessa, solo la Donna forte e coraggiosa che esiste in ogni donna.

Articolo marzo 2022

Campagna ENPAP 2022
#starebenefaremeglio#


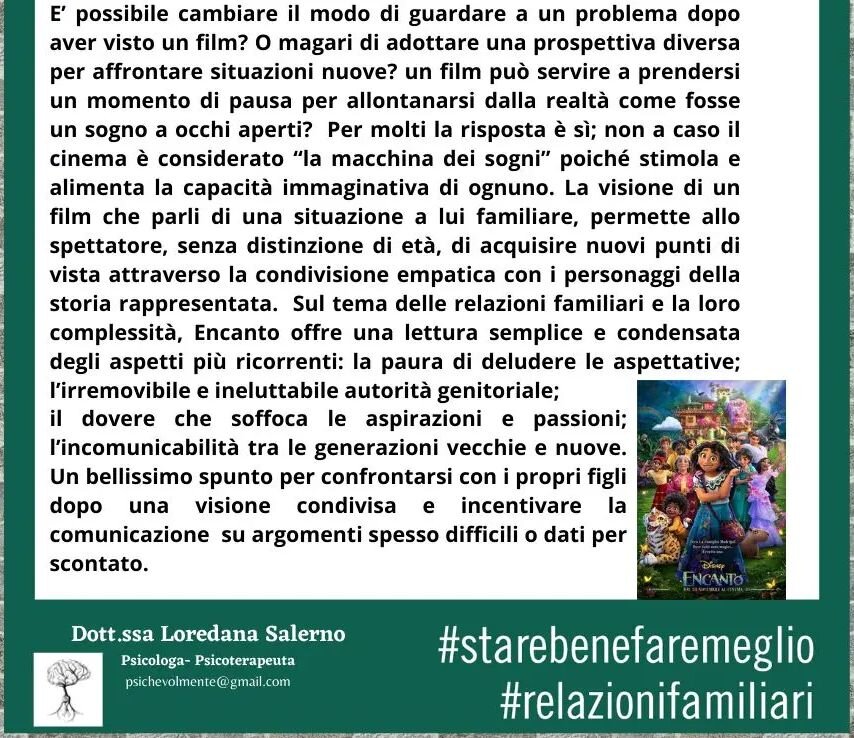


Psichevolmente